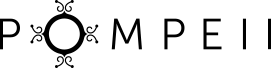Nella lettera, indirizzata al Banco di Napoli che cofinanziava lo scavo, Maiuri fa anche riferimento a ulteriori ragioni per proseguire l’indagine: quelle, per esempio, legate alla fruizione e all’“interesse turistico”, ma anche quelle scientifiche. Non si può, in effetti, comprendere un’opera singolare come la megalografia di II stile a tema dionisiaco che ha dato il nome alla villa, senza un inquadramento complessivo all’interno della villa, senza, in altre parole, conoscere il “contesto” dell’opera. Come gli altri obiettivi, anche questo è stato raggiunto.
Certo, dopo la pubblicazione esaustiva dello scavo nel 1931, appena un anno dopo la fine delle indagini sul campo e con i restauri in corso, la discussione sull’interpretazione del grande affresco è continuata, e la lettura delle scene è tuttora controversa. Dopo la scoperta di un’altra megalografia di II stile a tema dionisiaco nella “casa del Tiaso” all’inizio del 2025, crediamo di avere nuovi elementi per l’interpretazione del fregio dei Misteri, ma anche in questo caso non mancheranno voci divergenti ed è giusto che sia così (Zuchtriegel 2025). In ogni caso resta inconfutabile che con lo scavo dell’intera villa, Maiuri ha gettato le basi per una interpretazione scientificamente più fondata delle immagini e del loro contesto, anche se non esiste una lettura unitaria e forse non potrà mai esserci considerando che come ogni capolavoro, anche il fregio “dei Misteri” è contraddistinto da una intrinseca complessità che si oppone a schemi interpretativi semplici. Il tema di questo contributo, intanto, è alquanto lontano, sia concettualmente che fisicamente, dalle questioni ermeneutiche del fregio, verso il quale “è rivolto l’attenzione di tutto il mondo” (Maiuri). Il fatto è che Maiuri non ha scavato tutta la villa: a causa di un’abitazione che insisteva a Est del complesso, la facciata orientale verso la strada di campagna, che connetteva la villa con la vicina Pompei, e una parte del quartiere servile rimasero inesplorate. Solo dopo l’abbattimento dell’abitazione nel 2023, che nel corso del tempo era stata ampliata abusivamente arrivando a rappresentare un vero e proprio obbrobrio che letteralmente sovrastava la villa antica, adesso è possibile portare a termine l’opera del grande soprintendente. Il progetto varato dal Parco archeologico di Pompei si articola in più fasi. Dopo un primo intervento, concordato con la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, a seguito della scoperta di alcuni cunicoli clandestini che partivano dallo scantinato dell’abitazione abbattuta in direzione della villa, nel mese di aprile del 2025 è stato avviato un secondo intervento con l’obiettivo di congiungere lo scavo nell’area di sedime della casa abbattuta con l’ingresso della villa. Attualmente il Parco è impegnato nell’assicurare i fondi per uno scavo più esteso finalizzato a portare alla luce le strutture del quartiere servile ancora sepolte sotto lapilli e cenere (Mazzocchi et alii 2025).